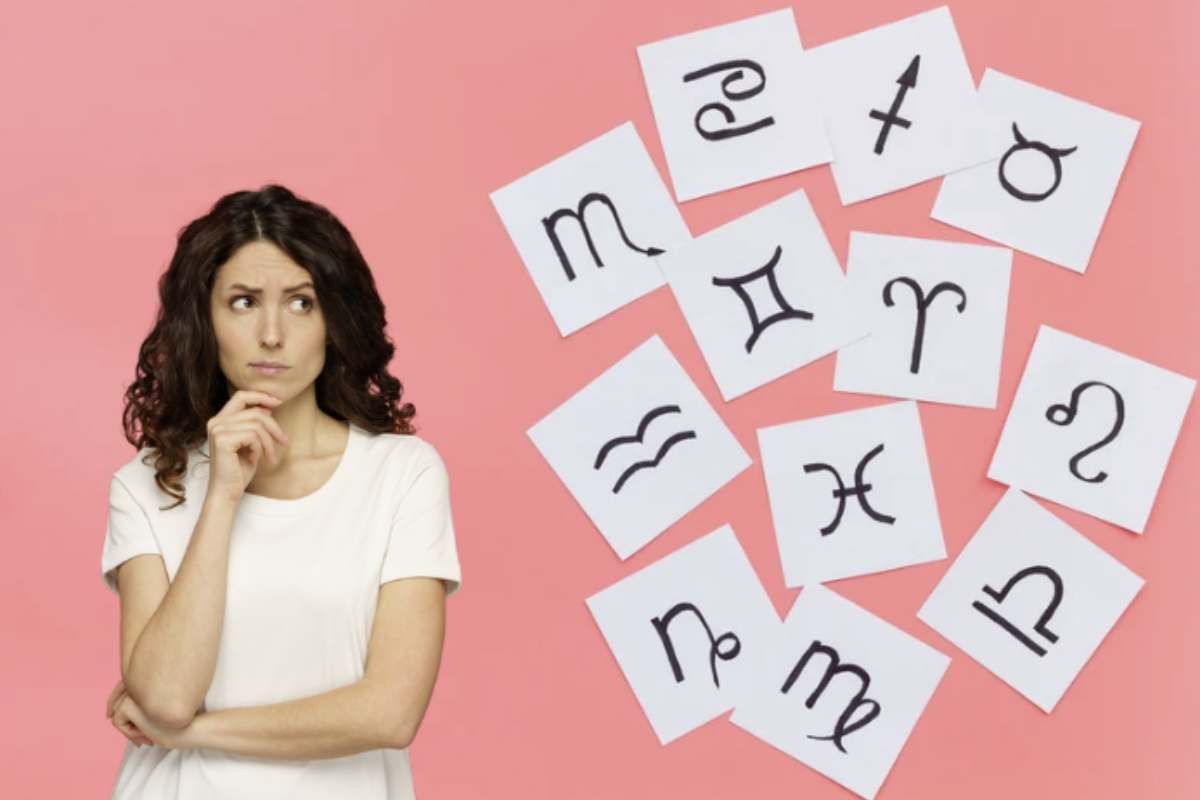In autunno, quando i grappoli d’uva raggiungono la piena maturazione, torna protagonista nelle cucine italiane il budino di uva.
Questa specialità, nota anche come sugolo o sugo d’uva, rappresenta un perfetto connubio tra semplicità degli ingredienti e ricchezza di sapore, ideale per chi desidera riscoprire i gusti autentici del territorio.
Il budino di uva nasce come preparazione tipica del periodo della vendemmia, quando le famiglie contadine utilizzavano gli acini maturi per creare un dessert semplice ma gustoso. La ricetta tradizionale prevede l’uso esclusivo di due ingredienti principali: l’uva, preferibilmente varietà ricche di succo come l’uva fragola, e la farina, spesso di grano o di mais, per addensare il composto. Talvolta, per chi ama un sapore più dolce, si aggiunge una moderata quantità di zucchero.
Il procedimento è laborioso e richiede pazienza: dopo aver raccolto gli acini, è necessario eliminare i semi e cuocere lentamente la frutta per estrarre il succo, che viene poi filtrato e addensato con farina o amido di mais (maizena). Successivamente, il budino viene fatto raffreddare in frigorifero fino a raggiungere la giusta consistenza gelatinosa. Il risultato è un dolce dalla colorazione intensa, che varia dal rosso rubino al viola scuro, e dal profumo avvolgente, profondo e leggermente acidulo, tipico dell’uva fresca.
Diffusione geografica e varianti regionali
Il sugolo, come è chiamato in diverse regioni d’Italia, gode di una diffusione multiregionale particolarmente significativa in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Qui, i piccoli budini di mosto d’uva sono spesso arricchiti con ingredienti tipici, come i semi di anice in Romagna o il pangrattato nelle varianti di Faenza, donando sfumature di gusto uniche.
Dal 2021, la versione mantovana del sugolo ha ottenuto la Denominazione Comunale d’Origine (De.C.O.) con il nome di crepada, così chiamata perché durante la cottura la buccia degli acini si rompe, conferendo al budino una consistenza e un aroma particolari. Inoltre, in Emilia-Romagna il sugolo è riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (P.A.T.), sottolineando il suo valore culturale e gastronomico.

Preparazione e consigli per la ricetta del budino di uva (www.notedicioccolato.it)
La preparazione del budino di uva fragola richiede attenzione e tempi di cottura calibrati. Gli acini vengono lavati e privati delle parti danneggiate, quindi messi a cuocere con una parte di zucchero e acqua fino a farli ammorbidire bene. Dopo una prima cottura, il composto viene passato al passaverdure per separare il succo dalle bucce. Il liquido recuperato è poi riportato a ebollizione insieme al resto dello zucchero.
L’ultimo passaggio prevede l’aggiunta dell’amido di mais, sciolto in acqua fredda, per far addensare il budino. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, il budino viene versato in coppette monoporzione, coperto con pellicola e lasciato raffreddare in frigorifero. Si conserva al massimo due giorni, tempo entro cui mantiene freschezza e consistenza ottimali.
Il budino di uva si presta a molteplici abbinamenti: può essere servito come dessert al cucchiaio, accompagnato da foglioline di menta fresca e acini d’uva, oppure come dolce da merenda nelle giornate più fresche di fine estate e inizio autunno.
La vendemmia: momento chiave per la qualità del budino
La buona riuscita del budino d’uva dipende in larga misura dalla qualità delle uve utilizzate, il cui raccolto avviene nel periodo della vendemmia, che in Italia si estende generalmente da luglio a ottobre, a seconda della latitudine, dell’esposizione del vigneto e della varietà coltivata.
La vendemmia manuale, ancora oggi pratica diffusa nelle aree vocate per vini di alta qualità, permette una selezione accurata dei grappoli, garantendo che vengano raccolti solo i frutti maturi e sani. Tale attenzione è fondamentale per ottenere un mosto dall’equilibrio ottimale tra zuccheri, acidi e aromi, elementi che si riflettono direttamente nel sapore del budino.
Inoltre, pratiche specifiche come la vendemmia scalare – che consiste nel raccogliere i grappoli in momenti successivi a seconda della maturazione – o la vendemmia tardiva, impiegata per aumentare la concentrazione zuccherina, possono influenzare le caratteristiche organolettiche del prodotto finale.

 Origini e tradizione del budino di uva(www.notedicioccolato.it)
Origini e tradizione del budino di uva(www.notedicioccolato.it)